Storia
Introduzione
Il Museo degli Innocenti racconta l’attività svolta dall’Istituto degli Innocenti nel corso della sua lunga storia grazie ad una relazione profonda tra opere d’arte, architettura, memoria e documentazione. L’insieme di questi elementi hanno dato luogo ad un patrimonio culturale davvero significativo e del tutto originale.
L’Istituto fu fondato nel 1419 sotto il patronato dell’Arte della seta per assistere i bambini abbandonati, grazie a un lascito testamentario del mercante pratese Francesco Datini e di altri mercanti fiorentini. La costruzione dell’edificio fu affidata a Filippo Brunelleschi. Come ogni altra struttura di accoglienza del periodo, prese il nome di Ospedale (o Spedale). La sua attività iniziò il 5 febbraio 1445, con l’arrivo della prima bambina, alla quale venne dato il nome di Agata e Smeralda.
l’Istituto continua ancora oggi la sua missione originaria di accoglienza di bambini e madri in difficoltà, insieme a nuove attività nell’ambito dei servizi per la prima infanzia e del sostegno alla genitorialità, nel campo della ricerca, della documentazione e formazione, sempre nella prospettiva della concreta affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Al suo interno è presente la Biblioteca Innocenti Alfredo Carlo Moro e la Bottega dei ragazzi- sezione educativa del Museo- che offre a scuole e famiglie laboratori creativi e didattici per bambini e ragazzi di tutte le età su temi legati all’arte, alla cultura e alla cittadinanza attiva, in linea con i valori e le attività svolte dall’Istituto degli Innocenti.
Il percorso museale si è arricchito di un nuovo spazio (di prossima apertura) – la Galleria degli affreschi – grazie al progetto PNRR del Ministero della cultura per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura pubblici. Posta lungo il quadrilatero brunelleschiano espone una raccolta di affreschi staccati ricevuti in deposito dalla Soprintendenza alla Gallerie fiorentine nel 1971, a seguito dell’Alluvione di Firenze del 1966.
Lungo il percorso museale è possibile avere anche l’affaccio sull’Archivio storico, che conserva la memoria dell’antico Ospedale e di coloro che lo hanno abitato.
All’ultimo piano, nella storica loggia, si trova il Caffè del Verone – ristoro del Museo- aperto a tutti. Dalla sua splendida terrazza si ammira la città e il panorama circostante. Visitare questo luogo, che rievoca il Rinascimento fiorentino e la sua nuova concezione dell’uomo, significa immergersi in una realtà unica, capace di suscitare emozione e interesse in ciascun visitatore, secondo la propria esperienza di visita.
Storia dell'Istituto
Nel 1419, la Corporazione dell’Arte della Seta di Por Santa Maria fu incaricata di realizzare l’Ospedale di Santa Maria degli Innocenti grazie a una donazione di mille fiorini da parte del mercante pratese Francesco Datini destinata all’accoglienza dell’infanzia abbandonata. La progettazione dell’edificio fu affidata a Filippo Brunelleschi, in quel momento impegnato anche nell’edificazione della cupola del Duomo di Firenze. L'Ospedale degli Innocenti divenne così “il luogo del bello” deputato ad accogliere i bambini abbandonati.
L’Ospedale venne inaugurato il 5 febbraio 1445, con l’arrivo della prima neonata, alla quale venne dato il nome di Agata e Smeralda, in onore della santa del giorno. La struttura offriva accoglienza a bambine e bambini lasciati in modo anonimo nella pila posta sotto il loggiato esterno, poi sostituita con una finestra ferrata, ancora oggi visibile vicino all’ingresso dell’Istituto.

I bambini al loro arrivo venivano affidati a un servizio di balie interne: donne povere, spesso ragazze sole o madri di bambini accolti proprio dall’istituzione. Con il passare del tempo divennero molto più numerose le balie esterne, presso le quali venivano mandati i piccoli. Vivevano preferibilmente in campagna, perché si riteneva che il clima e il cibo genuino favorissero la produzione di un buon latte, utile alla crescita degli esposti.
I sopravvissuti all’elevato tasso di mortalità infantile di quel tempo tornavano poi in Istituto: i bambini per frequentare la scuola e imparare un mestiere, le bambine per imparare a tessere o a occuparsi dei lavori domestici presso le famiglie agiate di Firenze, guadagnandosi la dote che avrebbe permesso loro di sposarsi o più raramente di entrare in convento.
Dal 1552 al 1580 fu introdotto dal priore Vincenzo Borghini un progetto educativo innovativo che includeva lo studio della musica, della pittura e dell’abaco. Le bambine, invece, potevano imparare a leggere, scrivere, cucire e tessere. Nel XVII secolo venne creato uno spazio attrezzato con telai per permettere alle ragazze di lavorare all’interno dell’Ospedale.
Tra il 1600 e il 1700 l’Ospedale iniziò ad accogliere le madri nubili tra le nutrici interne, le addette cioè a prestare le prime cure ai neonati, avviando così una prassi assistenziale anche nei confronti delle donne. Negli anni successivi queste iniziarono a ricevere un sussidio, un aiuto per costruirsi una vita anche fuori dall’Ospedale.

A partire dal 1700 l’attenzione si concentrò anche sulla salvaguardia della salute dei bambini, sviluppando ambiti specifici di indagine scientifica, promossa da medici illustri che studiavano nuovi metodi di allevamento e di cura delle patologie infantili. È in quest’epoca che iniziano le prime sperimentazioni di allattamento artificiale, di prevenzione antivaiolosa, di sviluppo della scienza ostetrica e pediatrica. Fin dalla sua istituzione l’Ospedale godette di privilegi, donazioni, eredità e ai suoi beni si aggiunsero quelli di altri enti. La gestione era affidata al Consiglio degli operai, nominati dall’Arte della seta. Con la abolizione delle Arti nel 1770, cessò il patrocinio della Corporazione dell’Arte della Seta. L’Ente fu posto sotto il controllo del governo granducale fino all’Unità d’Italia, ad eccezione del periodo della dominazione francese (1799-1814) in cui fu gestito unitariamente ad altri ospedali.
Nel 1862 divenne Opera pia, guidata dal 1888 da un Consiglio di Amministrazione. Il 30 giugno del 1875 venne abolito il sistema di ingresso anonimo, con la chiusura della finestra ferrata e fu istituito l’Ufficio di consegna. Nel 1890 con la legge Crispi, l’Ospedale divenne un istituto pubblico di beneficenza e nel 1923 Istituto pubblico per l’assistenza e la beneficenza (IPAB). Dal 1940 è stato denominato Istituto e dal 2004 è diventato Azienda di servizi alla persona (ASP).
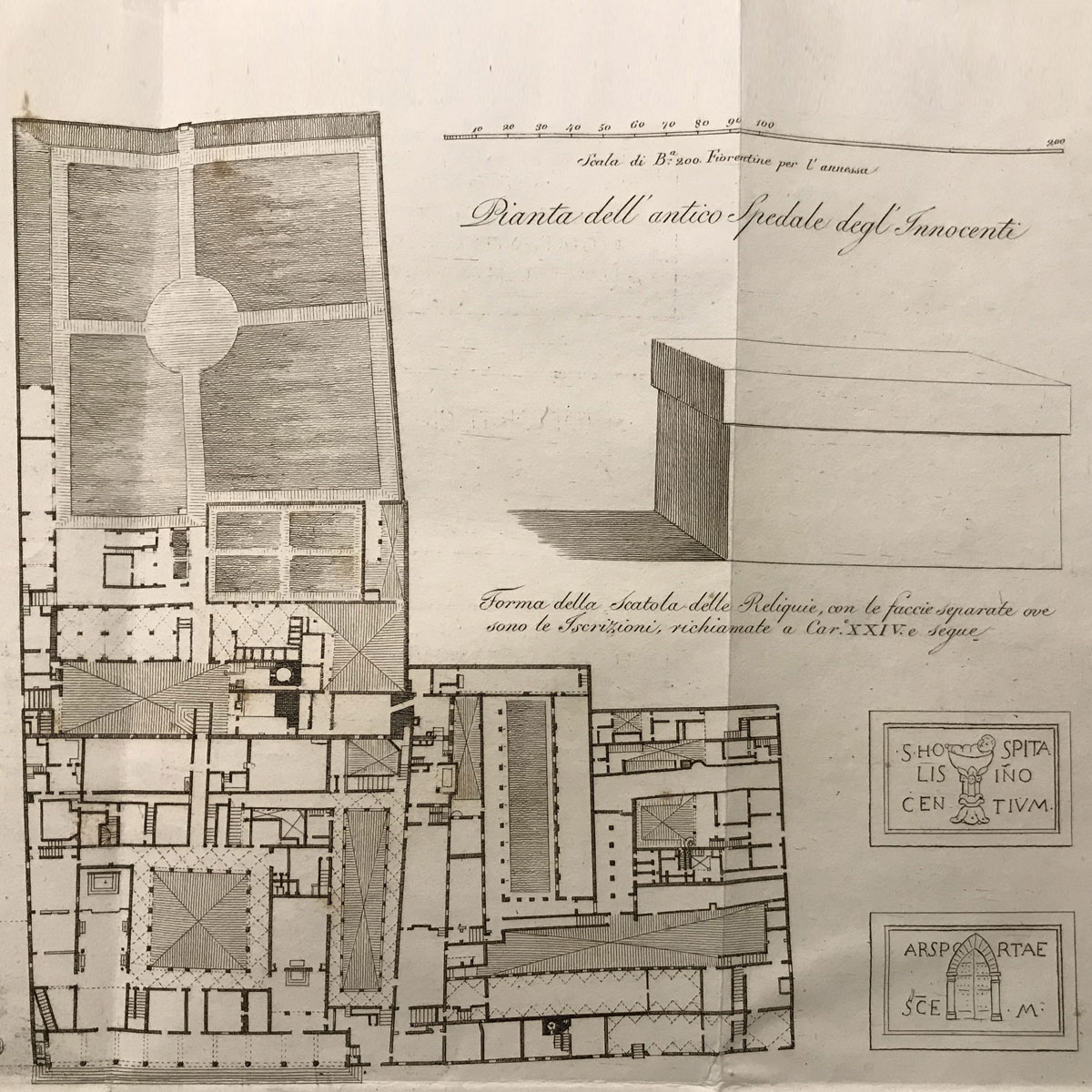
Oggi l’Istituto si occupa principalmente di:
- Accoglienza, educazione e sostegno alla genitorialità, realizzando e gestendo servizi di accoglienza rivolti a bambini e a famiglie in difficoltà, servizi educativi per bambini e genitori.
- Studio, ricerca e formazione sulla condizione di bambini e ragazzi a supporto delle politiche nazionali, regionali e locali e per la promozione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza: realizzando attività di ricerca, monitoraggio e documentazione su temi riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie e curando la formazione e l’aggiornamento professionale di chi lavora con bambini, ragazzi e famiglie. Gestisce le attività di documentazione e di monitoraggio del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, e del Centro regionale di documentazione per l’Infanzia e l’adolescenza.
- Tutela del patrimonio: valorizzando il proprio patrimonio storico-artistico, monumentale e archivistico attraverso attività di tutela e di promozione della storia dell’Istituto e della cultura dell’infanzia.
Storia del Museo
Nel corso dei secoli, l’antico Ospedale aveva raccolto numerose opere d’arte grazie a commissioni dirette, a importanti donazioni e all’accorpamento di altre istituzioni assistenziali. Nel 1853 l’Ente si trovò costretto a vendere una parte delle opere meno importanti per provvedere a un risanamento economico. Per le opere rimaste fu deciso un piano di conservazione che portò nel 1890 all’apertura del Museo al pubblico.
1890: Il Primo Allestimento
Venne realizzato in tre sale al piano terra, dove vennero esposte 77 opere ritenute più significative. Negli anni successivi il Museo fu ampliato ospitando opere prestigiose, quali l’Adorazione dei magi di Domenico Ghirlandaio, che si trovava originariamente sull’altare maggiore della Chiesa di S. Maria degli Innocenti, e altri materiali come l’Album fotografico realizzato dallo Stabilimento Brogi per presentare l’Ospedale all’Esposizione universale di Parigi del 1900.
Le guide pubblicate nel 1920 e nel 1926 documentano questo progressivo ampiamento del Museo e la sua trasformazione da quadreria in museo storico con l’obiettivo di presentare l’Ente nel suo insieme.

1971: Il Secondo Allestimento
Nel 1966, l’Alluvione che colpì Firenze sfiorò i locali al piano terra dell’Ospedale. Dopo il restauro dell’intero complesso monumentale, la collezione venne trasferita nella galleria sopra il porticato di ingresso (l’attuale Pinacoteca), al fine di mettere in sicurezza le opere. Questo nuovo allestimento mise in risalto i manufatti di grande valore artistico, ma relegò in secondo piano la relazione tra le opere e la storia dell’istituzione. In questa occasione fu ripristinata anche la galleria finestrata, posta nel quadrilatero che si affaccia sul Cortile degli uomini, identificata come Galleria degli affreschi (detta anche Galleria bassa). In questa furono collocate le sinopie e gli affreschi staccati provenienti dal Cenacolo di San Salvatore a Ognissanti e affidate in deposito all’Istituto dalla Soprintendenza alla Gallerie fiorentine. Il museo venne inaugurato il 27 giugno 1971.

2016: Il Terzo Allestimento
Nel 2016 venne inaugurato il nuovo Museo degli Innocenti, concepito per raccontare in modo più organico la relazione esistente tra la storia dell’Istituto, le opere raccolte e la sua struttura architettonica. Il Museo propone così tre percorsi di visita che si combinano tra loro - percorso Storia, percorso Arte e percorso Architettura – offrendo ai visitatori un’esperienza culturale originale nel panorama museale contemporaneo.


